«Quando ci spostiamo dalla politica dell’’Io’ a quella del ‘Noi’, riscopriamo quelle verità contro-intuitive che trasformano la vita: che un paese è forte quando si prende cura dei deboli, che diventa ricco quando si occupa dei poveri, che diventa invulnerabile quando presta attenzione ai vulnerabili. Se ci sta a cuore il futuro della democrazia dobbiamo recuperare quel senso di moralità condivisa che ci unisce l’uno all’altro in un legame di compassione e attenzione reciproche». È un appello potente quello lanciato da Jonathan Sacks dalle pagine di Morality, la sua ultima fatica ora tradotta anche in italiano (Moralità. Ristabilire il bene comune in tempi di divisioni, Giuntina, 416 pp.). Ultima, purtroppo, in senso pieno: l’ex rabbino capo della Gran Bretagna e del Commonwealth – filosofo, divulgatore e intellettuale pubblico di fama mondiale – si è spento pochi mesi dopo la pubblicazione del volume, nel novembre 2020.
«La sua scomparsa fa di questo testo davvero il suo testamento spirituale», conferma Ariel Di Porto, rabbino capo di Torino, filosofo egli stesso e grande studioso dei testi di Sacks. «Morality è in qualche modo il coronamento di un percorso di ricerca ed elaborazione, ma anche di insegnamento e coinvolgimento del pubblico, che Rav Sacks ha portato avanti per anni. Ma è soprattutto un grido d’allarme forte e disperato a tutta la società occidentale». Il punto di partenza ideale, ora che s’intravede la luce in fondo al tunnel della pandemia, per una riflessione d’insieme su ciò che resterà dell’epoca dei lockdown, sulle “risorse morali” necessarie in quella della ricostruzione, e sul ruolo possibile delle comunità religiose, in Italia e nel mondo.
Rav Di Porto, con l’uscita dalla fase più critica della pandemia ci accingiamo ad una sfida del tutto inedita per la nostra generazione, ma non per altre nella Storia: il ritorno alla socialità dopo un lungo periodo di buio e d’isolamento. C’è qualcosa che la tradizione biblica può insegnare su come affrontarla?

Ariel Di Porto, rabbino capo di Torino
Può essere interessante partire dal concetto stesso di quarantena, che come noto ha radici bibliche, mettendo in luce le similitudini ma anche le differenze con quanto abbiamo vissuto. Nella Torà la quarantena nasce come conseguenza della tzara’at – una malattia della pelle descritta nel libro del Levitico che è considerata in sostanza una punizione per un determinato comportamento. In modo particolare, secondo l’interpretazione rabbinica che emerge dal Talmud, essa è conseguenza di un errato uso della parola. Nel momento in cui tu non sei stato in grado di vivere all’interno della società – è la logica – allora ne vieni staccato, isolato per un dato periodo. Se questo è il concetto, possiamo dire che noi all’atto pratico non abbiamo affrontato davvero una quarantena: perché se è vero che non abbiamo avuto per molto tempo contatti umani fisici, abbiamo però continuato a parlare grazie ai nuovi mezzi tecnologici, e spesso a sparlare. Ecco, forse sul modo in cui abbiamo utilizzato e continueremo ad utilizzare questi strumenti è il tempo per tutti di una seria riflessione. Se ripenso al lavoro che hanno svolto delle nostre comunità ebraiche in risposta all’emergenza, abbiamo fatto moltissimo per fornire attività culturali, di studio e d’insegnamento – con una produzione e diffusione di lezioni senza precedenti; meno forse per cercare di compattare la collettività, per dedicarci al rapporto faccia a faccia con le persone, anche attraverso questi strumenti informatici. Ovviamente ciò va rapportato alle forze delle comunità, ma credo che sarebbe stato necessario un lavoro maggiore più basico – nel far parlare le persone, entrarci in contatto con regolarità, anche solo per augurare Shabbat Shalom («buon sabato»), chiedere «come va? che problemi ci sono? che possiamo fare?». E ho paura che adesso uscendo rischiamo nuovamente di lasciare dei pezzi per strada.
Qual è l’impatto di tutto ciò sulla fase della ricostruzione?
Il rischio è quello di correre e lasciare però indietro quelli che riescono a malapena a camminare. Chiaramente adesso ci sono delle priorità assolute – penso a quelle di natura economica anzitutto – ma non dobbiamo scordarci della dimensione sociale, di aiutare chi rischia di rimanere indietro. E non mi riferisco soltanto alle nostre comunità, ma alla società nel suo complesso.
Anche sulla scorta della testimonianza di Rav Sacks, in questo senso, le religioni potrebbero o dovrebbero forse abbandonare qualche timidezza reverenziale e impegnarsi in maniera più attiva con il proprio apporto di valori rispetto alle grandi sfide di quest’epoca?
Penso proprio di sì, e all’occorrenza anche in modo unitario. Nelle scorse settimane, per esempio, ricordavo in una riunione del Comitato Interfedi di Torino come noi dovremmo fare una campagna molto forte sui vaccini per i Paesi poveri, proprio per fare in modo che la ripartenza possa attecchire in maniera completa. Naturalmente è poi la politica a dover decidere, però sicuramente lanciare dei messaggi in questo senso può essere utile. E in questo schema Torino è un laboratorio molto interessante. Ci sono delle realtà cittadine e regionali – penso al Comitato Interfedi, al Comitato “Noi siamo con voi”, o ancora l Comitato per i diritti umani della Regione Piemonte – dove con gli esponenti delle diverse fedi si lavora molto e bene, secondo un meccanismo semplice ma che funziona: cerchiamo di individuare dei messaggi comuni, ci confrontiamo spesso e mettiamo a punto delle campagne, sia a livello di “cittadinanza attiva”, sia anche su questioni internazionali. E le idee e proposte che maturano vengono poi ascoltate dalle istituzioni, perché esse riconoscono al mondo religioso nel suo insieme una voce importante all’interno delle città e delle comunità nel senso più ampio.
Un modello da replicare anche su scala più ampia?
Sicuramente sì, perché sono proprio esperienze come queste a permettere di costruire quella moralità condivisa cui ci richiama Rav Sacks: l’Occidente sta un po’ perdendo la bussola, e le religioni hanno il vantaggio di avere una sovrastruttura ben sedimentata: e i messaggi chiave delle religioni sono tutto sommato abbastanza compatibili. Forme di collaborazione come queste allora possono dare un messaggio di speranza: far vedere che le religioni possono discutere e possono essere parte della soluzione.
Il filo conduttore di Morality è questa dicotomia di fondo per l’umanità tra la sfera dell’“Io” e quella del “Noi”, in cui la prima – ricostruisce Sacks – è venuta a prevalere decisamente sulla seconda negli ultimi decenni, sulla base di spinte politiche, economiche e culturali. Con la pandemia, dagli indizi osservati e raccolti nei mesi passati, è emersa più incoraggiata la spinta a cercare una collettività di cui non possiamo fare a meno, o più rafforzata paradossalmente la spinta egoistica – al ripiegarsi su se stessi, sui propri interessi ma anche le proprie angosce?
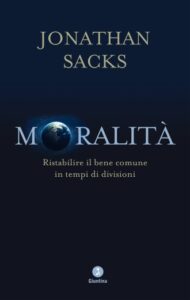
“Moralità”, l’ultimo libro del rabbino e filosofo Jonathan Sacks, è tradotto in italiano per Giuntina (pp. 416, € 19)
Io credo che dopo un isolamento che ha causato enorme sofferenza in tutte le fasce d’età ciò che prevale sia un grande bisogno di socialità: le persone hanno proprio bisogno di parlare. L’ho visto con chiarezza durante i mesi del lockdown, quando a volte mi capitava di mandare messaggi alle persone, dei semplici «Come stai?», e raccoglievo un’enorme gratitudine. Da una parte ti fa piacere, naturalmente, perché capisci che la tua funzione è apprezzata, ma dall’altra senti quanto davvero ci sia bisogno del contatto. Probabilmente sarà difficile almeno in questi primi frangenti riportare le persone a vivere secondo le modalità di una volta, a riabituarci a certi rapporti. Ma lo sforzo che dovremo fare sarà quello di scrollarci di dosso certe dinamiche di relazione che s’innescano tramite i social network che francamente non sono sostenibili. Penso al tema della gogna pubblica – troviamo dei messaggi di una violenza verbale che dal vivo non sarebbero ammissibili – o al disordine dei dibattiti: tutti pensano di poter dire qualsiasi cosa rispetto a qualsiasi argomento. Il mondo sicuramente non può basarsi su questi presupposti. Su questo sarà fondamentale lavorare, e su questo le comunità religiose possono dire la propria. Certo, come scrive Rav Sacks ne La dignità della differenza, le religioni non possono dare una risposta puntuale ai problemi del XXI secolo, non hanno gli strumenti tecnici per farlo; ma possono dare delle coordinate, possono fungere da bussola rispetto alla direzione da prendere. E rispondere a un bisogno fondamentale delle persone: quello di dare un significato alla vita, di dare un senso alla propria esistenza.
Oltre a questa missione fondamentale, Rav Sacks difende l’idea che le comunità di fede forniscano anche un senso di solidarietà e di appartenenza oggi indispensabile.
Sicuramente, questo è un tema fondamentale. La distanza che si è creata tra l’individuo e lo Stato non è mai stata tanta, perché storicamente c’è sempre stato qualcosa di mezzo: non necessariamente la comunità di fede. Ma è evidente che oggi le persone hanno sempre meno questi riferimenti intermedi – sia esso un partito politico, l’associazione di quartiere, la bocciofila: è ciò che Robert Putnam ha definito il “giocare a bowling da soli”[1], ed è molto pericoloso. E su questo le comunità di fede possono svolgere senza dubbio una funzione perché servono a legare le persone. E il fatto di avere più identità sovrapposte, delle multi-identità, è qualcosa che serve a scongiurare gli scontri violenti all’interno della collettività.
C’è purtroppo come ci mostra la Storia ma anche l’attualità un’altra possibile faccia della medaglia di tale forte coesione garantita dalle comunità di fede: il rischio che l’identità e l’appartenenza portate agli estremi diventino spinta all’esclusione se non addirittura alla violenza verso tutte le altre. Nessuna tra le grandi religioni ne è immune. Da un punto di vista ebraico, come si contiene questa tentazione?
Rav Sacks ha dedicato un libro intero, Non nel nome di Dio, a queste derive. E ne La Dignità della differenza, ha indicato quale può essere la via d’uscita. Chiaramente non si può arrivare a un pieno pluralismo religioso – questo non è ammissibile – cioè l’idea che tutte le religioni dal punto di vista teologico siano ugualmente vere; ma si possono riconoscere in qualche modo le ragioni dell’altro. Si può arrivare cioè ad una forma di cosiddetto inclusivismo religioso, che riconosce dignità all’altro. Su questo l’ebraismo tradizionale dà una risposta molto chiara: per essere salvo, per avere la salvezza a livello dottrinale, non è indispensabile essere ebreo. Abbiamo tanti esempi di non ebrei nella Bibbia che giungono poi alla salvezza e sono lodati per via dei loro comportamenti e del loro modo di essere. Ed in effetti il modello noachide si fonda proprio su di un patto che viene stretto con tutta l’umanità in vista di una costruzione virtuosa, che è appunto quella che Rav Sacks chiama, applicandola al mondo attuale, moralità: delle norme generalissime, condivise e accettabili per tutta l’umanità, che portino ad una situazione di equilibrio e di non conflitto. Il riconoscere l’umanità dell’altro è il passaggio fondamentale. Se s’innescano invece dinamiche di esclusione, il passaggio pericoloso è proprio quello della negazione dell’altro, della sua stessa umanità: e a quel punto qualsiasi nefandezza diviene possibile. Sacks lo spiega tracciando un parallelo con le lingue del mondo: ce ne sono moltissime diverse, certo, ma ci sono delle strutture fondamentali che ritornano e che sono in qualche modo applicabili a tutte. Lo stesso vale per i codici morali. È su questo che noi dovremmo insistere: non solo nel mondo religioso, pure nel dialogo con la società civile. Scegliendo degli obiettivi piano piano dovremmo cercare di elaborare, o recuperare, un linguaggio comune, di sviluppare una cultura della dialettica, del dialogo civile, del rispetto dell’avversario, e cercare di coinvolgere più persone possibili in questa impresa. Perché guardando a quanti al momento si trovano al di fuori di questa dimensione, arroccati sulle proprie posizioni e incapaci di parlare se non con persone simili a loro, è di impresa che si tratta. Ma io sono convinto che rimboccandoci tutti le maniche possiamo arrivare da qualche parte.
[1] R. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster Ltd, 2001. Edizione italiana: Capitale sociale e individualismo: crisi e rinascita della cultura civica in America, Il Mulino, 2004.






